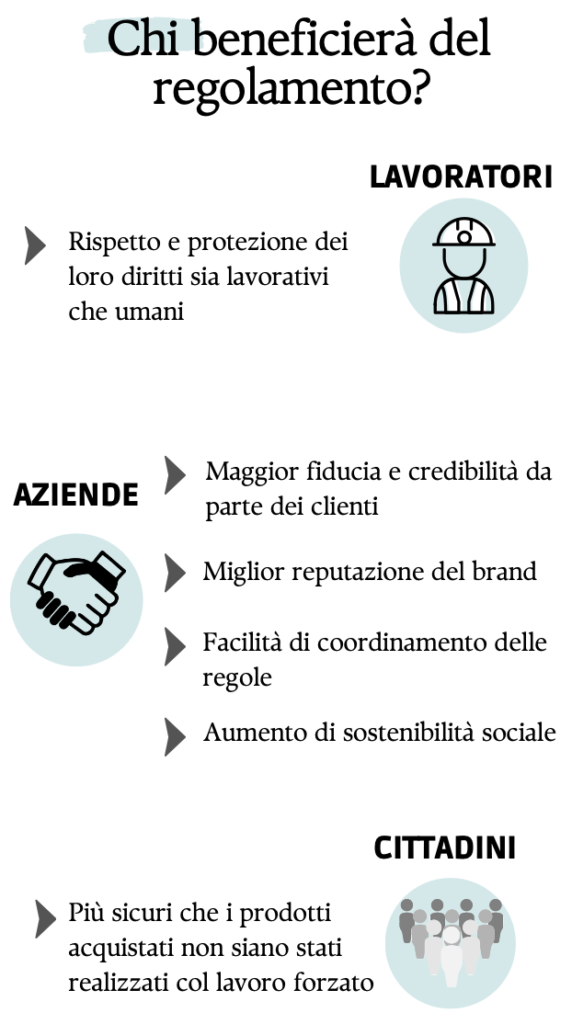La maestosa parata del 2 giugno: un’apoteosi di valori democratici e di orgoglio nazionale.
 Anche quest’anno, nel 78° anniversario della Repubblica, nostante il tempo uggioso e la pioggia battente, il cielo mattutino della Città eterna si è tinto di tricolore e le vie dell’Urbe hanno risuonato al passo cadenzato di una parata militare di incomparabile e rara bellezza, simbolo supremo dell’unità nazionale, della fedeltà e della dedizione incrollabile delle Forze Armate alla Patria.
Anche quest’anno, nel 78° anniversario della Repubblica, nostante il tempo uggioso e la pioggia battente, il cielo mattutino della Città eterna si è tinto di tricolore e le vie dell’Urbe hanno risuonato al passo cadenzato di una parata militare di incomparabile e rara bellezza, simbolo supremo dell’unità nazionale, della fedeltà e della dedizione incrollabile delle Forze Armate alla Patria.
In presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Capo Supremo delle Forze Armate, il quale ha nobilitato con la sua augusta partecipazione l’importanza dell’evento, la parata ha assunto una dimensione ancor più solenne. Un evento di straordinaria rilevanza – impreziosito dalla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto e delle più alte cariche dello Stato – che rappresenta non solo una cerimonia militare, ma prima di tutto una solenne celebrazione dei valori democratici della nostra amata Italia.
La rivista, che annualmente si svolge ai Fori Imperiali, nel cuore pulsante della Capitale, si è affermata anche stavolta come un appuntamento imperdibile per i cittadini italiani e – almeno per la maggioranza di essi – come un momento di sana riflessione patriottica e di atteso orgoglio collettivo.
Quest’anno, come sempre – dopo il doveroso omaggio delle più alte cariche dello Stato al sacello del Milite Ignoto – la manifestazione, aperta da una rappresentanza dei sindaci d’Italia, ha visto sfilare i vari corpi delle Forze Armate, i reparti speciali e le unità storiche, i mezzi, gli aerei e i quadrupedi, in un susseguirsi di quadri marziali che hanno esaltato la disciplina, il coraggio e l’abnegazione di donne e uomini che quotidianamente si prodigano per la sicurezza e la salvaguardia della Nazione.
Nel rassicurante clangore delle lance e delle sciabole, in un colorato ma composto connubio di pennacchi piume, penne, mostrine, alamari, ghette e cordellini, accanto alle Forze Armate, accompagnate dalle note di bande e fanfare, anche le Forze di Polizia e le componenti del soccorso pubblico hanno reso omaggio alla Repubblica, esibendo la loro instancabile ed indispensabile opera di tutela della legalità e di pronto intervento in situazioni di emergenza.
In questa edizione hanno sfilato per la prima volta anche i rappresentanti dell‘Unità di Crisi della Farnesina e delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Non è una mera e vuota esaltazione di forza, bensì una celebrazione della democrazia, dell’amor di Patria, dello spirito di corpo e di appartenenza che caratterizzano le nostre Forze Armate.
Gli Italiani si stringono attorno alle loro Forze Armate. Le Forze Armate si stringono intorno agli Italiani. Così è stato oggi e così dovrebbe essere sempre.
Un evento che rispecchia l’essenza stessa dei valori costituzionali su cui si fonda la nostra veneranda Repubblica.
Oggi, qui, la forma si è fusa con la sostanza.
Tante facce pulite, che si intravedono anche dietro a qualche mephisto.
Un’aria da bravi ragazzi e brave ragazze, “acqua e sapone”, che cela però cuori impavidi, valori immutabili e professionalità di altissimo valore.
Dai cavalieri agli incursori, dai marinai ai piloti, dal Carabiniere di quartiere alle operazioni spaziali, le nostre Forze Armate sono il luogo dove albergano la fedeltà, la giustizia, la bellezza, l’onestà, l’onore, il sacrificio.
In un’epoca in cui le sfide globali sono sempre più intricate, gli uomini e le donne con le stellette si ergono come un baluardo di stabilità e sicurezza, impegnate sia sul fronte interno che nelle missioni per la pace e la cooperazione internazionali.
Le Forze Armate italiane non si limitano alla difesa del territorio nazionale; il loro impegno si estende anche al supporto delle popolazioni afflitte da calamità naturali, offrendo assistenza umanitaria e aiuto concreto nei momenti di maggior bisogno.
La partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali con vocazione securitaria come la NATO, l’ONU e altre importanti alleanze globali e regionali, testimonia il ruolo fondamentale del nostro Paese nella promozione della pace e della sicurezza mondiale.
Ma la parata di quest’anno può stimolare gli addetti ai lavori – e non solo – a pensare all’attuale apertura delle nostre Forze Armate verso nuove sfide, alcune delle quali sono già in corso.
L’integrazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresenta un passo importante verso uno strumento militare più moderno e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze e ai diritti dei suoi membri, nonostante la complessità di un quadro giuridico in via di rapida definizione.
Inoltre, la visione di un esercito europeo, sebbene ancora in fase embrionale, inizia a prendere lentamente forma, riflettendo il desiderio di una difesa comune più coesa e razionale all’interno dell’Unione europea, in termini sia economici e industriali che valoriali e politici.
La concreta solidarietà all’Ucraina, devastata da un conflitto che ha sconvolto la comunità internazionale, rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno italiano per la difesa della democrazia e della libertà oltre i confini nazionali.
Le Forze Armate italiane, con il loro contributo, ribadiscono il loro ruolo cruciale nella promozione della pace e della sicurezza globale.
L’Italia è da sempre impegnata affinché tutti gli attori internazionali rispettino il diritto internazionale umanitario, che mai può cedere il passo al pur sacrosanto diritto all’autodifesa. Questa ferma posizione, oggi più che mai, sottolinea l’importanza della giustizia e della legalità anche nei contesti più difficili, promuovendo un ordine internazionale basato sulla cooperazione e il rispetto reciproco.
I critici che vedono in questa parata un atto muscolare di militarismo fine a sé stesso, o – peggio – un pericoloso e vago atto di fanatismo per capitoli ormai risalenti della nostra storia, dimostrano di non cogliere la profondità e il significato dell’evento.
E, come scritto in passato su queste pagine virtuali: chi non gradisce le uniformi, chi le teme, chi addirittura le attacca ha la coscienza sporca o, quanto meno, non è in pace con sé stesso.
Al contrario, chi vi partecipa o vi assiste con occhi attenti può percepire l’autentico spirito di servizio e la dedizione che anima la compagine militare.
Un servizio che non conosce confini, ma che si estende ovunque vi sia bisogno di proteggere e promuovere i valori democratici e costituzionali.
Il rumore delle critiche, spesso superficiali e infondate, non deve infatti distogliere l’attenzione dal vero scopo della parata: esaltare e onorare coloro che, con sacrificio e abnegazione, operano quotidianamente per il bene della Nazione.
Coloro che mettono a repentaglio la propria vita, spesso in modo drastico e fatale, per garantire la sicurezza di tutti, meritano rispetto e riconoscenza.
Non basterebbero svariati volumi per descrivere gli innumerevoli esempi di eroismo compiuti dai nostri soldati in Patria e all’estero.
Ne sono un esempio le rappresentanze degli atleti paralimpici e dei mutilati e invalidi della Difesa che hanno avuto un ruolo di primo piano nell’odierna celebrazione.
In maniera sicuramente elementare e tautologica, è noto come la nostra componente mililtare operi da sempre a favore dell’Italia e per l’Italia: possedere delle Forze Armate costituisce uno dei capisaldi di qualsiasi entità che voglia definirsi “statuale”, perché le Forze Armate rappresentano espressione della sovranità di qualunque Stato, che voglia definirsi tale e che abbia anche un territorio e un popolo.
Questo è pacifico.
Ma, al contrario e in maniera forse anche un po’ infantile, nel nostro caso specifico, occorrerebbe chiedersi se sia davvero possibile pensare all’Italia senza le sue Forze Armate.
La risposta è scontata, perché – che piaccia o no – la storia del nostro Paese è legata da sempre a doppio filo a quella delle sue Forze Armate e, proprio durante le vere difficoltà e le crisi profonde, gli Italiani hanno guardato non a caso alle Forze Armate per la propria salvezza e la propria sicurezza.
Che piaccia o no, le Forze Armate rappresentano la nostra identità. Fortunatamente.
La parata militare che si svolge a Roma e le altre manifestazioni di analogo tenore che si tengono in altre città non sono soltanto un evento celebrativo, ma un importante simbolo di unità e di valori condivisi.
Grazie alla visione lungimirante dell’attuale leadership istituzionale, la celebrazione del 2 giugno si è confermata come un appuntamento fondamentale per la vita realmente democratica del nostro Paese.
Non è solo una festa della Difesa, ma una festa di tutti gli Italiani e come tale dovrebbe essere sentita e vissuta.
Un’occasione per tutti i cittadini per rinnovare l’impegno verso la Patria e per riscoprire il valore dell’appartenenza a una Nazione che, forte delle sue radici e dei suoi ideali, guarda con fiducia e speranza al futuro.
Avevamo scritto qui, su European Affairs Magazine, della necessità di ripensare e di esaltare lo strumento militare, specie dopo gli inenarrabili sacrifici profusi dai nostri soldati durante la pandemia.
Finalmente, sembra che quanto auspicato in termini di considerazione e tributo alle Forze Armate, quale simbolo di unità nazionale e punto di riferimento per tutti, si stia concretizzando.
Finalmente, perché non è stato sempre così.
Ancora una volta, grazie alle nostre Forze Armate… e viva l’Italia!

 Mentre in Europa abbiamo reinventato la Guerra Fredda nell’illusione di fermare la storia, cullandoci nel decadente mito della superiorità della cultura occidentale, sorretti dalla presunzione di avere il diritto di imporre sanzioni a chiunque non condivida la nostra narrative, il mondo si è trasformato sotto i nostri occhi.
Mentre in Europa abbiamo reinventato la Guerra Fredda nell’illusione di fermare la storia, cullandoci nel decadente mito della superiorità della cultura occidentale, sorretti dalla presunzione di avere il diritto di imporre sanzioni a chiunque non condivida la nostra narrative, il mondo si è trasformato sotto i nostri occhi.
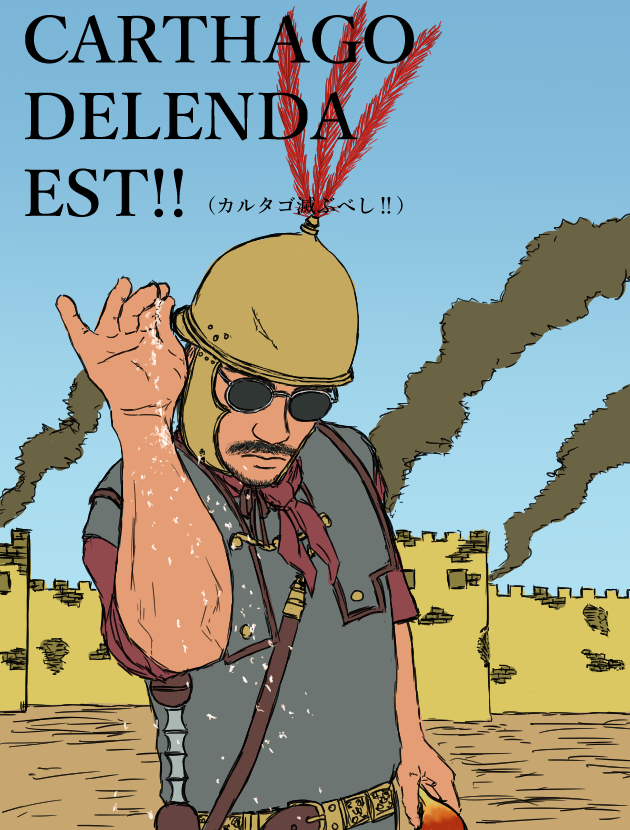
 Un anno fa la Turchia sembrava essere al margine della scena geopolitica internazionale, isolata diplomaticamente, aspramente criticata per la leadership di Erdogan, ininfluente nel complesso flusso delle relazioni che condizionano l’aerea mediorientale e mediterranea, priva di peso politico e quindi destinata ad assumere una posizione di paria internazionale.
Un anno fa la Turchia sembrava essere al margine della scena geopolitica internazionale, isolata diplomaticamente, aspramente criticata per la leadership di Erdogan, ininfluente nel complesso flusso delle relazioni che condizionano l’aerea mediorientale e mediterranea, priva di peso politico e quindi destinata ad assumere una posizione di paria internazionale. Nei giorni scorsi la firma di una tregua ha consentito l’inizio dei negoziati di pace che hanno posto termine alla guerra civile che ha visto fronteggiarsi per oltre due anni il Governo Etiope e i separatisti del Tigrai. Questa guerra, segnata da eccessi di violenza e crimini da ambo le parti, ha causato più di 500.000 morti, provocato oltre due milioni di profughi e ha distrutto il tessuto sociale di un’intera regione.
Nei giorni scorsi la firma di una tregua ha consentito l’inizio dei negoziati di pace che hanno posto termine alla guerra civile che ha visto fronteggiarsi per oltre due anni il Governo Etiope e i separatisti del Tigrai. Questa guerra, segnata da eccessi di violenza e crimini da ambo le parti, ha causato più di 500.000 morti, provocato oltre due milioni di profughi e ha distrutto il tessuto sociale di un’intera regione.
 I conflitti sono sempre stati originati e condotti per ottenere risultati volti a soddisfare il conseguimento degli intendimenti strategici che le nazioni considerano essenziali per i loro obiettivi di politica nazionale.
I conflitti sono sempre stati originati e condotti per ottenere risultati volti a soddisfare il conseguimento degli intendimenti strategici che le nazioni considerano essenziali per i loro obiettivi di politica nazionale.