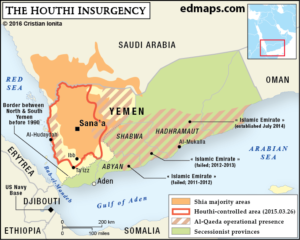Gli Stati Arabi e la crisi ucraina
 La risposta negativa da parte degli Stati Arabi del Golfo o meglio la mancata adesione alle richieste americane di condanna della Russia, per l’invasione dell’Ucraina, ha posto l’accento sulle relazioni tra gli USA e i Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), evidenziando il crescente scetticismo che viene riservato al ruolo degli Stati Uniti quale tradizionale partner privilegiato nell’aerea.
La risposta negativa da parte degli Stati Arabi del Golfo o meglio la mancata adesione alle richieste americane di condanna della Russia, per l’invasione dell’Ucraina, ha posto l’accento sulle relazioni tra gli USA e i Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), evidenziando il crescente scetticismo che viene riservato al ruolo degli Stati Uniti quale tradizionale partner privilegiato nell’aerea.
La posizione di strategica neutralità assunta dal GCC deriva dalla mutata impostazione geopolitica dell’area, dove l’espansione della influenza economico-politica della Cina e della Russia ha creato una nuova realtà multipolare che da tempo ha messo in discussione la leadership americana.
Le difficoltà dei rapporti USA – GCC sono originate rispettivamente dalla declinante fiducia nell’impegno degli Stati Uniti a garantire la sicurezza dei Paesi Arabi alleati e da parte USA dal disappunto per politiche regionali che ostacolano e rendono complesso il conseguimento degli obiettivi geopolitici americani.
Nel particolare, infatti, le relazioni tra gli USA e i Paesi del GCC, improntate sul binomio energia e sicurezza, hanno subito nel tempo un deterioramento causato da una serie di fattori che hanno caratterizzato, nell’ultimi quindici anni, la visione strategica USA nell’area evidenziandone una limitata profondità geopolitica.
Sotto il punto di vista dell’approvvigionamento energetico, la ricerca e il conseguimento dell’autonomia nel settore dei combustibili fossili attuato dagli USA ha generato l’errata asserzione che la produzione di energia degli Stati del GCC non avesse più un valore strategico. Anzi l’espansione dell’attività USA nel settore specifico è stata percepita come una concorrenza volta ad alterare il conseguimento di una collaborazione per conferire equilibrio al mercato globale dei combustibili, in un momento di particolare e delicata transizione verso fonti alternative.
Da qui è derivata la crescita di importanza della Russia nell’ambito dell’OPEC+ quale elemento di stabilità e di affidabilità nella gestione delle risorse energetiche fossili.
Per quanto attiene al concetto di sicurezza, questo ha rappresentato, da sempre, la principale ragione d’essere della presenza USA nella regione e delle sue positive relazioni con i Paesi del GCC.
La fiducia riposta nell’impegno a garantire la protezione agli alleati contro le minacce alla loro sicurezza e nella capacità di assicurare un equilibrio politico nell’area mediorientale è stata messa in discussione e si è incrinata per una serie di scelte politico – diplomatiche che hanno messo in dubbio l’importanza strategica dell’area nella visione americana.
L’inconsistenza politica e la ingenuità dimostrata nella gestione della cosiddetta Primavera Araba, il ruolo ambiguo e marginale svolto nel conflitto siriano, la scarsa considerazione delle esigenze di Paesi del GCC nella stipulazione degli accordi sul nucleare (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) con l’Iran, Paese che è percepito come la principale minaccia alla stabilità dell’area, le continue dichiarazioni di interesse prioritario verso lo scacchiere Indo Pacifico nel tentativo di contrastare la sfida della crescente influenza cinese, hanno determinato uno scetticismo sempre maggiore nei confronti della determinazione americana a svolgere quel ruolo di garante della sicurezza che assicurava la stabilità dell’area, ritenuta fondamentale dai Paesi del GCC.
Scetticismo che è stato ulteriormente, aumentato dall’atteggiamento estremante attivo assunto dagli USA nella crisi ucraina (e dalle pressioni esercitate su Paesi del GCC per condannare la Russia) e dalla considerazione inerente alle risorse militari offerte all’Ucraina, giudicate quantitativamente sproporzionate in relazione a quelle rese disponibili per supportare gli alleati mediorientali nella loro domanda di sicurezza.
Nel particolare sono le relazioni dirette con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti che hanno maggiormente sofferto questo calo di fiducia nell’impegno USA nella regione ed è proprio verso questi due Paesi che si sono rivolte con più attenzione le iniziative politico economiche della Cina.
Pechino ha iniziato da lungo tempo una politica di penetrazione commerciale volta ad inserirsi nell’area mediorientale occupando tutti gli spazi lasciati vacanti dalla poco attenta visione USA.
Se, sino ad ora, le attività cinesi sono state condotte con circospezione evitando di poter essere considerate come attacco diretto volto a distruggere le relazioni di alleanza tra GCC e USA, le conseguenze della crisi ucraina hanno aperto nuove possibilità all’azione diplomatico economica della Cina.
Recenti incontri di vertice della Cina con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno reso chiara l’intenzione di Pechino di adottare una linea politica più decisa e più aperta nel sostegno degli interessi nazionali finalizzati all’acquisizione di una posizione dominante nell’area.
La posizione di strategica neutralità dei Paesi GCC assunta nei confronti della Russia, finalizzata a non danneggiare gli ottimi rapporti stabiliti con Mosca (stabilizzazione della crisi siriana e gestione congiunta delle quote di greggio) sono stati recepiti da Pechino come un segnale positivo nell’ambito di eventuali azioni intese a risolvere la questione di Taiwan. Inoltre, la rinnovata disponibilità alla partecipazione attiva al grande progetto della Belt and Road Initiative (B&RI) ha comportato la stesura di una serie sempre maggiore di accordi e partneship commerciali che hanno portato alla realizzazione di enormi investimenti da parte di Pechino.
Il risultato di questi accordi ha avuto due importanti conseguenze che hanno ulteriormente indebolito la posizione USA.
La prima è quella dell’inclusione della regione mediorientale in uno scacchiere geopolitico che oramai ha spazzato via tutti i precedenti riferimenti, estendendosi senza soluzione di continuità dall’Europa all’Asia globalizzando e trasformando il concetto di relazioni internazionali.
La seconda, strettamente connessa alla prima è quella della condivisone con Pechino di una visione strategica dove non esistono più vincoli all’ingresso nell’area di potenze esterne come l’India in aggiunta, ovviamente, alla presenza della Cina e della Russia, sulla base della ricerca di un sempre maggior volume di investimenti e di attività di cooperazione non solo limitate alla sfera economico commerciale.
L’aspetto fondamentale per i Paesi del GCC è la partecipazione a un mercato più ampio, dove gli investimenti e le partnership economiche offrono l’accesso a tecnologie e risorse indispensabili per affrontare la trasformazione da una società basata sullo sfruttamento delle energie fossili a un mondo con accesso a fonti alternative. Ed è questa la chiave di volta su cui si basa la strategia di Pechino!
Offrire un fondamentale supporto per l’accesso alle nuove tecnologie, proporsi come partner privilegiato nella transizione verso fonti rinnovabili e nell’attesa costituire il maggior partner per l’acquisto del greggio, senza pretendere come condizione pregiudiziale il rispetto di regole e di comportamenti sociali ritenuti intrusivi e moralmente inadeguati.
Attraverso il conseguimento di questi obiettivi Pechino vede la possibilità di creare un cuneo politico tra i Paesi del GCC e il loro principale attuale alleato, dando luogo a una revisione degli equilibri geopolitici.
Il fine ultimo non sembra essere quello di ricoprire un ruolo egemonico sostituendosi agli Stati Uniti ma, invece, di creare una specie di direttorato con Russia e India, escludendo progressivamente gli Stati Uniti da un’area che è la cerniera tra lo scacchiere Indo Pacifico e quello Euroasiatico.
Controllando tale area economicamente, finanziariamente e politicamente (ma non solo, in quanto si sta sviluppando anche una certa presenza militare cinese negli Emirati), la Cina creerebbe le condizioni migliori per la sicurezza degli assi di penetrazione marittimo e terrestre sui quali si articolala sua B&RI e che sono diretti al cuore economico del Vecchio Continente!!!!!
Nello stesso tempo la possibilità di coinvolgere in questa nuova realtà geopolitica sia la Russia (rivitalizzata nel ruolo di grande potenza) sia l’India (gigante che ancora si deve alzare in piedi) mediante la condivisone di una visione strategica comune, senza l‘Occidente, che focalizzerebbe questi due partner geopolitici in un’area di intervento lontana dalle coste cinesi dell’Asia e dal Pacifico lasciando alla Cina il ruolo di arbitro di questo nuovo ordine mondiale.
Questo è lo scenario che si può preconizzare in base all’analisi delle mosse che un Occidente, sempre più cieco, sempre più rinchiuso in sé stesso, privo di una visione politica a lungo raggio, prigioniero dei suoi ideali e delle sue idiosincrasie concettuali, ha messo in atto per contrastare una crisi, quella ucraina, che se pure frutto di un comportamento moralmente inaccettabile da parte russa, in qualche modo ha contribuito a stimolare e che non è in grado di affrontare con provabilità di successo.
Ma questo scenario non è stato ancora concretizzato, c’è ancora tempo e c’è ancora spazio per una ripresa da parte dell’Occidente che, con le risorse immense umane, morali ed economiche che possiede ha le capacità per proporre un’alternativa geopolitica a Cina e Russia in grado di sostenere lo sviluppo, la cooperazione e la partnership economica dei Paesi del GCC pur non abiurando al pieno rispetto dei principi universali di libertà e democrazia su cui si basa l’Occidente.
Ovviamente non solo solo gli Stati Uniti che devono riprendere alla mano una vera linea di politica mondiale, ma anche l’Europa è chiamata a liberarsi dal torpore egoistico dei sui Stati membri che ne tiene frenate le energie e a darsi degli obiettivi concreti e unitari da conseguire.