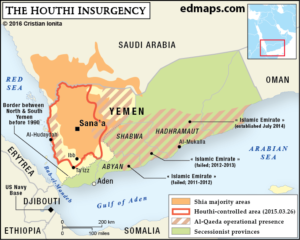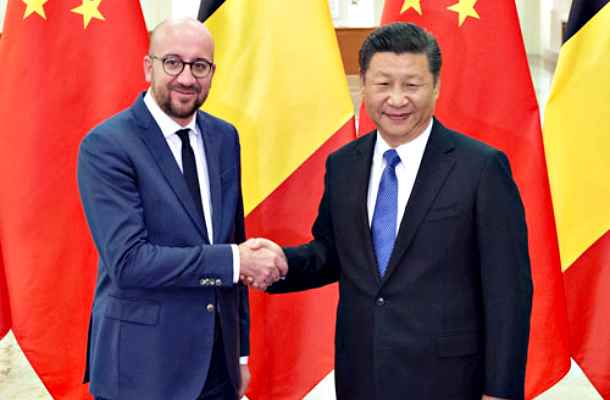KF-21, il nuovo prototipo di jet da combattimento dell’industria aeronautica sudcoreana
La Corea del Sud prevede di schierare 120 jet da combattimento entro il 2032.
Il presidente Moon Jae-in ha annunciato il piano venerdì presso lo stabilimento Korea Aerospace Industries Co. a Sacheon, (Corea del Sud) durante una cerimonia di lancio del prototipo del suo primo jet da combattimento, il KF-21, soprannominato Boramae, o “giovane falco addestrato per la caccia”.
Moon si è congratulato con gli ingegneri e gli altri funzionari dietro l’impresa, dicendo che ha aperto una nuova era per la difesa della Corea del Sud.

Il primo test di volo è previsto per il 2022, mentre lo sviluppo completo dovrebbe essere completato entro il 2026. Una volta operativo, il jet KF-21 dovrebbe essere armato con diverse tipologie di missili. I caccia bimotore arriveranno nelle versioni monoposto e biposto, a seconda delle missioni a cui sono assegnati.
Moon ha detto che dopo il completamento dei test di volo e di terra, la produzione di massa del KF-21 inizierà con un obiettivo di 40 jet dispiegati entro il 2028 e 120 entro il 2032.
“Ora abbiamo il nostro jet da combattimento supersonico avanzato prodotto a livello nazionale. Siamo diventati l’ottavo paese al mondo a farlo. È una pietra miliare storica nello sviluppo dell’industria aeronautica sudcoreana”.
Nella sola fase di sviluppo sono stati creati circa 12mila posti di lavoro, anche grazie ad una produzione nazionale del 65 percento dei componenti KF-21.
“Quando inizierà la produzione di massa su vasta scala, verranno creati 100.000 posti di lavoro aggiuntivi e avremo un valore aggiunto di 5,9 trilioni di won coreani (5,2 miliardi di dollari). L’effetto sarà molto maggiore se vengono esportati”, ha detto Moon.
La Corea del Sud dovrebbe produrre sei prototipi KF-21 per test e sviluppo, i primi tre da completare entro la fine di quest’anno e i prossimi tre nella prima metà del 2022, secondo la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) del paese.
Il governo ha fissato l’obiettivo di investire anche in nuove tecnologie innovative, come gli aerei elettrici e a idrogeno, e la mobilità dell’aviazione urbana.
La Corea del Sud ha presentato per la prima volta la sua visione per un jet locale nel 2001 e da allora ha continuato il lavoro di ricerca. Nel 2015, il Paese ha iniziato a lavorare al progetto, del valore di 7,9 miliardi di dollari, in collaborazione con l’Indonesia che ha accettato di finanziarne il 20% e di ricevere 50 dei 170 jet in totale.
Durante la cerimonia per il lancio del prototipo venerdì scorso il presidente Moon ha ringraziato l’Indonesia per la sua fiducia nella Corea del Sud nello sviluppo congiunto del combattente dicendo che Seoul lavorerà con Jakarta per fare breccia in altri mercati.