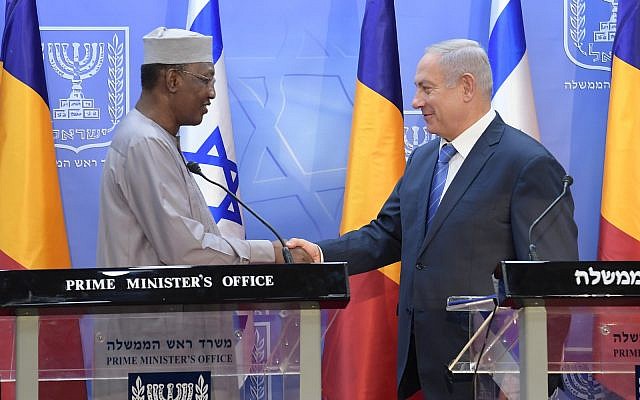Vox entra in Parlamento, ma le aspettative erano diverse
Il miraggio degli incontri di massa durante la campagna elettorale si è schiantato con la realtà delle schede elettorale alle urne. Vox, che aveva nutrito aspettative di un trionfo epico, ha conquistato un risultato molto più prosaico. Il partito ultranazionalista, finora fuori dal parlamento, ha ottenuto più di due milioni e mezzo di voti, il 10,3% del totale, e 24 seggi alla Camera dei Deputati, ma non sarà decisivo per la formazione di un governo (visto che non raggiunge la maggioranza alleandosi con il Partido Popular e Ciudadanos) e deve accontentarsi di essere la quinta forza politica in Spagna.
I leader di Vox si sono affrettati a rispondere a coloro che li accusavano di aver lasciato strada libero a Pedro Sanchez dopo aver diviso il voto della destra. Per prima cosa è stato il segretario del partito, Javier Ortega Smith, che ha accusato il PP e Ciudadanos di “non essere stati capaci di sconfiggere la sinistra settaria del Governo di Spagna”. E poi lo stesso Santiago Abascal, ha affermato che l’unica responsabilità è per “incapacità, slealtà, tradimenti e paure” della “destra codarda”, riferendosi al suo vecchio partito, il PP, per non essersi opposto alla sinistra quando aveva 186 deputati, maggioranza assoluta, con Rajoy. È stato il PP, ha continuato, a consegnare “le televisioni, i media e l’educazione alla dittatura progressista”. Abascal ha ammesso che per il suo partito, il verdetto delle urne è stato “una gioia, ma anche una preoccupazione”, non è sufficiente “per spodestare il fronte popolare, così che la “Spagna è peggio oggi rispetto a ieri” e “Vox è sempre più necessario”. Ha espresso il suo “profondo rispetto per il risultato elettorale”, ma ha avvertito che nessuna maggioranza legittima potrà intraprendere una riforma costituzionale che comprenda il diritto all’autodeterminazione, il perdono per i responsabili di processi separatisti o imporre leggi totalitarie, riferendosi alla legge delle memoria storica o a quella della violenza di genere. Per un partito extraparlamentare, irrompere in Parlamento con una ventina di deputati e moltiplicare per cinquanta volte i suoi voti nelle ultime elezioni generali dovrebbe essere motivo di festa. Tuttavia, i leader di Vox avevano gonfiato le loro aspettative così tanto che la sensazione è stata quella di delusione il giorno dopo il voto. Abascal diceva che i sondaggi erano sbagliati e che molte società demoscopiche avrebbero dovuto chiudere per non aver pronosticato il trionfo del suo partito, per poi constatare che il risultato è stato molto al di sotto di quanto veniva previsto da tutti i sondaggi, in cui venivano assegnati tra i 29 e i 37 seggi al partito di estrema destra. Vox ha scelto come quartier generale per la notte elettorale l’Hotel Fenix, in un angolo di Plaza Colòn, dove Abascal ha iniziato e chiuso la sua campagna elettorale, e a pochi metri dalla sede el PP, in Calle Genova, il partito in cui ha militato per 19 anni. Più di 280 giornalisti, molti stranieri, hanno chiesto di essere accreditati, ma solo 84 di questi hanno potuto accedere alla piccola sala stampa. Poco dopo la chiusura delle urne, il presidente di Vox a Madrid e candidata alla Comunidad, Rocio Monsterio, è apparsa davanti ai media per fare una breve dichiarazione e senza ammettere nessuna domanda. Dopo aver ringraziato il lavoro svolto da tutta la squadra di Vox, ha assicurato che nel nuovo Parlamento ci “saranno molti deputati di Vox” che combatteranno “con fermezza e determinazione per l’unità del Paese, la libertà e l’uguaglianza degli spagnoli”. Allo stesso tempo, il capo lista di Barcellona, Ignacio Garriga, aveva predetto che il suo partito avrebbe ottenuto 70 deputati, gli stessi che ha ottenuto Podemos nel 2016. Mentre il conteggio proseguiva, la sala dove i leader del partito seguivano i risultati è stata chiusa e le poche facce che uscivano erano tutte di cattivo umore. Verso le 22.30, con quasi l’80% dei voti scrutinati, Ortega è dovuto uscire per sollevare gli spiriti di tutti i sostenitori radunati fuori il quartier generale che contemplavano in silenzio, attraverso un grande maxi schermo, il frantumarsi del loro sogno. Il numero due di Vox ha assicurato che, d’ora in poi, i suoi deputati “saranno l’unica opposizione” all’esecutivo socialista, la cui vittoria è stata predetta come “effimera”. Ortega ha invitato i suoi assordanti seguaci a ritenersi “molto soddisfatti e orgogliosi” di quello che hanno ottenuto nonostante l’esclusione del partito dai dibattiti televisivi e la mancanza di risorse pubbliche che hanno gli altri partiti.
Nelle elezioni andaluse dello scorso dicembre, Vox ha ottenuto 395.978 voti, il 10,97% del totale, entrando nel Parlamento autonomo con 12 seggi. Nelle elezioni generale del 2016 ha ottenuto solo 46.881 voti, lo 0,2%. Il suo miglior risultato nelle elezioni statali è stato ottenuto nelle europee del maggio 2014, pochi mesi dopo la sua nascita, dove ha conquistato 244.929 voti, l’1,56%, non ottenendo nemmeno un seggio a Strasburgo.
Di Mario Savina