
Hong kong in rivolta cerca libertà o combatte la miseria?
Le dimostrazioni ad Hong Kong sono nate contro la decisione del potere centrale di Pechino di stringere piu’ o pesantemente il pugno sull’autonomia della città. La legge che avrebbe imposto anche per i residenti il trasferimento sul continente per il processo qualora ritenuti sospetti di certi reati. Leggi Tutto




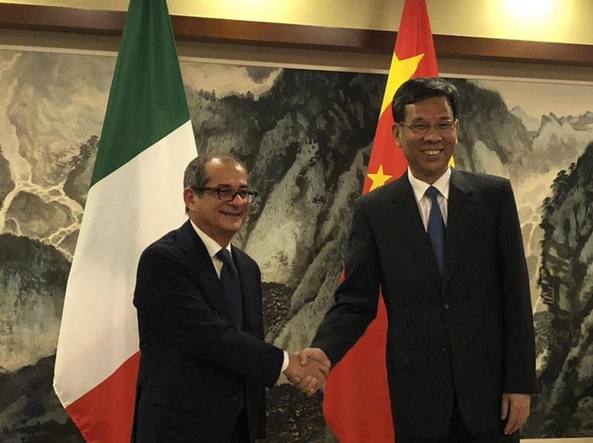


 A Washington la lobby israeliana è molto forte e, assieme a quella saudita e al conglomerato dei produttori di armi, è considerata tra quelle con maggiore capacità di penetrazione nei centri decisionali statunitensi. Il genero di Trump è ebreo di origine e ben ammanicato con il Likud. Contemporaneamente, è amico personale dell’erede al trono saudita Mohamed bin Salman. E’ quindi un uomo chiave sia per rinfrescare i rapporti con Netanyahu che per avvicinare quel Paese con l’Arabia Saudita ed entrambi con la nuova politica americana. C’e’ però un altro uomo che va considerato: è Sheldon Adelson, il “re di Las Vegas”, che fu il maggior finanziatore della campagna elettorale di Trump. Anch’egli è di origine ebraica, amico di Netanyahu e si è fatto notare come fautore della minaccia nucleare da usarsi contro Tehran. Anche tra i neo-conservatori, oggi non più in vista come ai tempi di Bush figlio ma sempre influenti, c’è chi giudicò un errore l’attacco fatto a Saddam Hussein perché, sostengono, sarebbe stato più opportuno dichiarare guerra all’Iran piuttosto che all’Iraq. A questo proposito ricordo una conversazione con Michael Leeden avvenuta poco dopo l’inizio dell’attacco: era furioso perché capiva che eliminare Saddam avrebbe significato aprire le porte agli iraniani. Era, al contrario, fortemente convinto che si dovesse invece attaccare l’Iran con ogni mezzo e che, sconfitti gli Ayatollah, anche Saddam si sarebbe riallineato con gli USA.
A Washington la lobby israeliana è molto forte e, assieme a quella saudita e al conglomerato dei produttori di armi, è considerata tra quelle con maggiore capacità di penetrazione nei centri decisionali statunitensi. Il genero di Trump è ebreo di origine e ben ammanicato con il Likud. Contemporaneamente, è amico personale dell’erede al trono saudita Mohamed bin Salman. E’ quindi un uomo chiave sia per rinfrescare i rapporti con Netanyahu che per avvicinare quel Paese con l’Arabia Saudita ed entrambi con la nuova politica americana. C’e’ però un altro uomo che va considerato: è Sheldon Adelson, il “re di Las Vegas”, che fu il maggior finanziatore della campagna elettorale di Trump. Anch’egli è di origine ebraica, amico di Netanyahu e si è fatto notare come fautore della minaccia nucleare da usarsi contro Tehran. Anche tra i neo-conservatori, oggi non più in vista come ai tempi di Bush figlio ma sempre influenti, c’è chi giudicò un errore l’attacco fatto a Saddam Hussein perché, sostengono, sarebbe stato più opportuno dichiarare guerra all’Iran piuttosto che all’Iraq. A questo proposito ricordo una conversazione con Michael Leeden avvenuta poco dopo l’inizio dell’attacco: era furioso perché capiva che eliminare Saddam avrebbe significato aprire le porte agli iraniani. Era, al contrario, fortemente convinto che si dovesse invece attaccare l’Iran con ogni mezzo e che, sconfitti gli Ayatollah, anche Saddam si sarebbe riallineato con gli USA. L’Europa, per ora, ha dichiarato che intende tenere sicuramente fede agli impegni sottoscritti nel 2015 e altrettanto hanno fatto Cina e Russia. Se gli Stati Uniti dovessero rimanere isolati nel sottrarsi allo JCPOA, Rohani, con l’aiuto di Khamenei (se ci sarà), potrebbe riuscire a tacitare le richieste dei conservatori che vorrebbero riprendere con urgenza l’arricchimento dell’uranio. Ciò che serve ai “moderati” è che le aperture economiche europee, gli investimenti promessi e l’arrivo di nuovo know how comincino a realizzarsi. Qualora ciò non avvenisse e Bruxelles dovesse accodarsi agli americani, a Tehran rimarrebbe l’appoggio della Russia e, teoricamente, anche della Cina. Recentemente, Rohani ha compiuto una visita di Stato in India firmando accordi economici importanti tra cui uno per l’ammodernamento delle ferrovie iraniane con investimenti e tecnologia indiana. Si è recato anche in Turchia e Russia per rinsaldare i legami che gia’ li vedono collaborare in Siria e ottenere rassicurazioni.
L’Europa, per ora, ha dichiarato che intende tenere sicuramente fede agli impegni sottoscritti nel 2015 e altrettanto hanno fatto Cina e Russia. Se gli Stati Uniti dovessero rimanere isolati nel sottrarsi allo JCPOA, Rohani, con l’aiuto di Khamenei (se ci sarà), potrebbe riuscire a tacitare le richieste dei conservatori che vorrebbero riprendere con urgenza l’arricchimento dell’uranio. Ciò che serve ai “moderati” è che le aperture economiche europee, gli investimenti promessi e l’arrivo di nuovo know how comincino a realizzarsi. Qualora ciò non avvenisse e Bruxelles dovesse accodarsi agli americani, a Tehran rimarrebbe l’appoggio della Russia e, teoricamente, anche della Cina. Recentemente, Rohani ha compiuto una visita di Stato in India firmando accordi economici importanti tra cui uno per l’ammodernamento delle ferrovie iraniane con investimenti e tecnologia indiana. Si è recato anche in Turchia e Russia per rinsaldare i legami che gia’ li vedono collaborare in Siria e ottenere rassicurazioni. L’Iran è certamente un paese giudicato interessantissimo da tutte le aziende europee per il potenziale sviluppo economico che promette, ma non va dimenticato che il mercato americano rappresenta gia’ per tutti i Paesi europei produttori uno sbocco molto più grande e gia’ acquisito. Con tutta la buona volontà di non cedere alle pressioni di oltre oceano bisogna anche sapere che alcuni tipi di prodotto, come ad esempio gli aerei di Airbus, hanno componenti fabbricati negli Stati Uniti e non potranno quindi più essere venduti all’Iran. In questo settore, proprio in considerazione dell’arretratezza dell’aviazione locale, Tehran aveva firmato contratti per l’acquisto di un centinaio di aerei dalle due compagnie, Airbus e Boeing, ma soltanto poche unità sono state consegnate e per le altre sarà impossibile procedere.
L’Iran è certamente un paese giudicato interessantissimo da tutte le aziende europee per il potenziale sviluppo economico che promette, ma non va dimenticato che il mercato americano rappresenta gia’ per tutti i Paesi europei produttori uno sbocco molto più grande e gia’ acquisito. Con tutta la buona volontà di non cedere alle pressioni di oltre oceano bisogna anche sapere che alcuni tipi di prodotto, come ad esempio gli aerei di Airbus, hanno componenti fabbricati negli Stati Uniti e non potranno quindi più essere venduti all’Iran. In questo settore, proprio in considerazione dell’arretratezza dell’aviazione locale, Tehran aveva firmato contratti per l’acquisto di un centinaio di aerei dalle due compagnie, Airbus e Boeing, ma soltanto poche unità sono state consegnate e per le altre sarà impossibile procedere. Oltre all’Europa, la più grande incognita di oggi è sapere quel che farà la Cina, sia dal punto di vista politico sia economico. Se Pechino continuerà a tenere fede allo JCPOA e quindi non applicherà le sanzioni, si creerà, nei fatti, un fronte politico che andrà dalla Turchia a Mosca a Pechino, passando per il Pakistan o, in alternativa, l’India. La Cina ha ottimi rapporti con Islamabad ma pessimi con l’India, l’Iran ne ha buoni con l’India e così così con il Pakistan. L’Arabia Saudita ha invece ottimi contatti da molto tempo con quest’ultimo e, in funzione di un’accentuata ostilità verso Tehran, cercherà sicuramente di avere un appoggio nel vecchio amico. Comunque si pongano le cose in Medio Oriente e in Asia centrale, l’isolamento voluto dall’Occidente nei confronti dell’Iran (se l’Europa si accoderà alle posizioni americane), spingerà il Paese nelle braccia accoglienti di Pechino, com’è gia’ successo con la Russia. Gia’ oggi la presenza cinese in Iran è pervasiva: per le strade non si vedono molti cinesi (non sono generalmente amati) ma i loro capitali sono disseminati in tutto il territorio. Durante le sanzioni precedenti, anche la Cina ufficialmente le rispettava ma, tramite triangolazioni o artifici vari, le sue merci invadevano fabbriche e negozi iraniani. A Washington sono consapevoli del rischio politico ed economico di uno “sfilarsi” cinese e certamente eserciteranno, anche in quella direzione, tutte le pressioni che saranno loro possibili. Per Pechino, come per l’Europa, il mercato americano è più importante che qualunque altro e lo dimostra la volontà di negoziare ad ogni costo dopo le minacce sui dazi. Si consideri che il commercio cinese con gli USA lo scorso anno è stato di circa 636 miliardi di dollari mentre con l’Iran il volume era attorno ai 38 miliardi. Fino ad ora, la politica della Cina è sempre stata quella di apparire il più possibile neutrale in ogni crisi che avvenisse lontana dal loro territorio. Così è per la questione Israelo-Palestinese, per i litigi nel Golfo che coinvolgono Iran, Saudia e Qatar e anche per la guerra siriana. E’ però vero che più il tempo passa e più l’economia cinese si sviluppa, più la politica estera di Pechino diventa assertiva, come si è visto nel Mar Cinese del Sud. Prima o poi, i nuovi “Mandarini” dovranno esplicitare l’ambizione, per ancora taciuta, di voler assurgere al ruolo di prima potenza mondiale e quella della crisi con l’Iran potrebbe anche essere l’occasione. Oggettivamente, è improbabile che davvero lo diventi ma qualora ciò avvenisse (e se la guerra commerciale con Washington dovesse davvero scoppiare, tutto diventa più probabile) costituirebbe un importante passo su quella strada espansionistica cominciata in silenzio da almeno venti anni.
Oltre all’Europa, la più grande incognita di oggi è sapere quel che farà la Cina, sia dal punto di vista politico sia economico. Se Pechino continuerà a tenere fede allo JCPOA e quindi non applicherà le sanzioni, si creerà, nei fatti, un fronte politico che andrà dalla Turchia a Mosca a Pechino, passando per il Pakistan o, in alternativa, l’India. La Cina ha ottimi rapporti con Islamabad ma pessimi con l’India, l’Iran ne ha buoni con l’India e così così con il Pakistan. L’Arabia Saudita ha invece ottimi contatti da molto tempo con quest’ultimo e, in funzione di un’accentuata ostilità verso Tehran, cercherà sicuramente di avere un appoggio nel vecchio amico. Comunque si pongano le cose in Medio Oriente e in Asia centrale, l’isolamento voluto dall’Occidente nei confronti dell’Iran (se l’Europa si accoderà alle posizioni americane), spingerà il Paese nelle braccia accoglienti di Pechino, com’è gia’ successo con la Russia. Gia’ oggi la presenza cinese in Iran è pervasiva: per le strade non si vedono molti cinesi (non sono generalmente amati) ma i loro capitali sono disseminati in tutto il territorio. Durante le sanzioni precedenti, anche la Cina ufficialmente le rispettava ma, tramite triangolazioni o artifici vari, le sue merci invadevano fabbriche e negozi iraniani. A Washington sono consapevoli del rischio politico ed economico di uno “sfilarsi” cinese e certamente eserciteranno, anche in quella direzione, tutte le pressioni che saranno loro possibili. Per Pechino, come per l’Europa, il mercato americano è più importante che qualunque altro e lo dimostra la volontà di negoziare ad ogni costo dopo le minacce sui dazi. Si consideri che il commercio cinese con gli USA lo scorso anno è stato di circa 636 miliardi di dollari mentre con l’Iran il volume era attorno ai 38 miliardi. Fino ad ora, la politica della Cina è sempre stata quella di apparire il più possibile neutrale in ogni crisi che avvenisse lontana dal loro territorio. Così è per la questione Israelo-Palestinese, per i litigi nel Golfo che coinvolgono Iran, Saudia e Qatar e anche per la guerra siriana. E’ però vero che più il tempo passa e più l’economia cinese si sviluppa, più la politica estera di Pechino diventa assertiva, come si è visto nel Mar Cinese del Sud. Prima o poi, i nuovi “Mandarini” dovranno esplicitare l’ambizione, per ancora taciuta, di voler assurgere al ruolo di prima potenza mondiale e quella della crisi con l’Iran potrebbe anche essere l’occasione. Oggettivamente, è improbabile che davvero lo diventi ma qualora ciò avvenisse (e se la guerra commerciale con Washington dovesse davvero scoppiare, tutto diventa più probabile) costituirebbe un importante passo su quella strada espansionistica cominciata in silenzio da almeno venti anni.
 Anche in Siria, le forze di combattimento curde sono state indispensabili per la sconfitta dell’ISIS. Dopo la strenua difesa di Kobane ampiamente coperta dai media occidentali, i curdi avevano dato vita ad un esercito che, oltre ai locali Peshmerga, comprendeva gruppi arabi uniti a loro nella lotta contro i terroristi. Nella Siria degli Assad i curdi non erano considerati cittadini come gli altri e non godevano della cittadinanza o degli stessi diritti degli altri cittadini. Piu’ volte erano stati aperti contatti con il Governo di Damasco per ottenere un riconoscimento o una qualche autonomia gestionale, ma sempre con scarso successo. Allo scoppio del fenomeno ISIS e non parteggiando per Assad, le comunità curde avevano approfittato della situazione per creare una loro “zona franca” e impedire allo Stato Islamico e a chiunque altro di entrare nei loro territori. Ciò aveva consentito all’esercito siriano di concentrare le proprie forze su altri campi di battaglia, lasciando che fossero i curdi stessi a contrastare il comune nemico in quelle aree. Chi non si disinteressò, invece, di ciò che succedeva in quei luoghi fu la Turchia che denunciò il locale partito PYD di essere legato al PKK (considerato internazionalmente un gruppo terrorista curdo-turco). I Peshmerga siriani, la forza armata del partito denominata YPG, fu accusata immediatamente di ricevere armi e ordini dal PKK. La cosa è verosimile, anche se sia il PYD si l’YPG hanno sempre smentito ogni collegamento. Per questi motivi, durante l’assedio di Kobane, Ankara impedì che curdi di Turchia potessero unirsi ai difensori della città e, solo dopo le pressioni internazionali, consentì che vi arrivassero Peshmerga del partito iracheno PDK, considerati più vicini ai propri interessi. Va però aggiunto che, almeno in un primo tempo e non ufficialmente, armi turche erano a disposizione dello Stato Islamico per essere usate sia contro Saddam sia contro i curdi di Siria. La preoccupazione della Turchia era, fin dall’inizio, che una possibile caduta del regime di Damasco consentisse la nascita di una nuova enclave curda vicino al proprio confine. Se fosse nata una regione amministrata da curdi o addirittura se fosse nato uno Stato curdo in Siria, ciò avrebbe galvanizzato i seguaci del PKK incoraggiandoli nella loro lotta e rendendo piu’ difficile bloccare il desiderio di autonomia curda all’interno della Turchia. Anche quando Ankara, dopo l’accordo con i russi, virò decisamente a favore della lotta contro gli Islamisti, la preoccupazione che nessuna enclave curda potesse nascere in Siria continuò a essere presente nei suoi incubi.
Anche in Siria, le forze di combattimento curde sono state indispensabili per la sconfitta dell’ISIS. Dopo la strenua difesa di Kobane ampiamente coperta dai media occidentali, i curdi avevano dato vita ad un esercito che, oltre ai locali Peshmerga, comprendeva gruppi arabi uniti a loro nella lotta contro i terroristi. Nella Siria degli Assad i curdi non erano considerati cittadini come gli altri e non godevano della cittadinanza o degli stessi diritti degli altri cittadini. Piu’ volte erano stati aperti contatti con il Governo di Damasco per ottenere un riconoscimento o una qualche autonomia gestionale, ma sempre con scarso successo. Allo scoppio del fenomeno ISIS e non parteggiando per Assad, le comunità curde avevano approfittato della situazione per creare una loro “zona franca” e impedire allo Stato Islamico e a chiunque altro di entrare nei loro territori. Ciò aveva consentito all’esercito siriano di concentrare le proprie forze su altri campi di battaglia, lasciando che fossero i curdi stessi a contrastare il comune nemico in quelle aree. Chi non si disinteressò, invece, di ciò che succedeva in quei luoghi fu la Turchia che denunciò il locale partito PYD di essere legato al PKK (considerato internazionalmente un gruppo terrorista curdo-turco). I Peshmerga siriani, la forza armata del partito denominata YPG, fu accusata immediatamente di ricevere armi e ordini dal PKK. La cosa è verosimile, anche se sia il PYD si l’YPG hanno sempre smentito ogni collegamento. Per questi motivi, durante l’assedio di Kobane, Ankara impedì che curdi di Turchia potessero unirsi ai difensori della città e, solo dopo le pressioni internazionali, consentì che vi arrivassero Peshmerga del partito iracheno PDK, considerati più vicini ai propri interessi. Va però aggiunto che, almeno in un primo tempo e non ufficialmente, armi turche erano a disposizione dello Stato Islamico per essere usate sia contro Saddam sia contro i curdi di Siria. La preoccupazione della Turchia era, fin dall’inizio, che una possibile caduta del regime di Damasco consentisse la nascita di una nuova enclave curda vicino al proprio confine. Se fosse nata una regione amministrata da curdi o addirittura se fosse nato uno Stato curdo in Siria, ciò avrebbe galvanizzato i seguaci del PKK incoraggiandoli nella loro lotta e rendendo piu’ difficile bloccare il desiderio di autonomia curda all’interno della Turchia. Anche quando Ankara, dopo l’accordo con i russi, virò decisamente a favore della lotta contro gli Islamisti, la preoccupazione che nessuna enclave curda potesse nascere in Siria continuò a essere presente nei suoi incubi. Come abbiamo visto, la situazione economica della Regione Autonoma Curda si trova oggi in gravi difficoltà, perfino piu’ pesante dopo la perdita di Kirkuk e la rinuncia del Presidente Barzani ad accettare una proroga del suo mandato. Il Governo di Al Abadi è uscito finora vincente dal confronto e sta cercando di capitalizzare quanto ottenuto imponendo ai curdi condizioni inaccettabili che costituiscono un passo indietro perfino rispetto all’autonomia prevista dalla Costituzione e alle libertà di cui già godevano. I posti di frontiera con l’Iran sono stati rimessi in funzione e dal 16 gennaio sembrerebbe che anche un accordo per la riapertura degli aeroporti possa essere raggiunto. Tuttavia, tra le condizioni poste ( ben tredici) per iniziare nuove negoziazioni ci sono: a)la dichiarazione scritta che il referendum sia considerato totalmente nullo, b)la rinuncia ad ogni futura richiesta di indipendenza, c)negli aeroporti curdi di Erbil e Suleimaniya devono essere presenti rappresentanti permanenti dell’Autorità dell’Aviazione Civile Irachena, d)tutti i valichi frontiera, compresi quelli con la Turchia, devono non essere piu’ controllati da forze curde ma solo da quelle irachene, e)tutti i pubblici ufficiali curdi che vogliono recarsi all’estero per qualunque motivo devono ottenere l’autorizzazione da Baghdad, f)tutti i futuri proventi doganali o derivanti dalla vendita di petrolio devono essere lasciati alle autorità Federali e la vendita degli idrocarburi deve essere effettuata solo attraverso la SOMO (l’Ente petrolifero nazionale), g)il controllo delle dighe su territorio curdo dovrà passare sotto il controllo dello Stato centrale, ecc.
Come abbiamo visto, la situazione economica della Regione Autonoma Curda si trova oggi in gravi difficoltà, perfino piu’ pesante dopo la perdita di Kirkuk e la rinuncia del Presidente Barzani ad accettare una proroga del suo mandato. Il Governo di Al Abadi è uscito finora vincente dal confronto e sta cercando di capitalizzare quanto ottenuto imponendo ai curdi condizioni inaccettabili che costituiscono un passo indietro perfino rispetto all’autonomia prevista dalla Costituzione e alle libertà di cui già godevano. I posti di frontiera con l’Iran sono stati rimessi in funzione e dal 16 gennaio sembrerebbe che anche un accordo per la riapertura degli aeroporti possa essere raggiunto. Tuttavia, tra le condizioni poste ( ben tredici) per iniziare nuove negoziazioni ci sono: a)la dichiarazione scritta che il referendum sia considerato totalmente nullo, b)la rinuncia ad ogni futura richiesta di indipendenza, c)negli aeroporti curdi di Erbil e Suleimaniya devono essere presenti rappresentanti permanenti dell’Autorità dell’Aviazione Civile Irachena, d)tutti i valichi frontiera, compresi quelli con la Turchia, devono non essere piu’ controllati da forze curde ma solo da quelle irachene, e)tutti i pubblici ufficiali curdi che vogliono recarsi all’estero per qualunque motivo devono ottenere l’autorizzazione da Baghdad, f)tutti i futuri proventi doganali o derivanti dalla vendita di petrolio devono essere lasciati alle autorità Federali e la vendita degli idrocarburi deve essere effettuata solo attraverso la SOMO (l’Ente petrolifero nazionale), g)il controllo delle dighe su territorio curdo dovrà passare sotto il controllo dello Stato centrale, ecc.